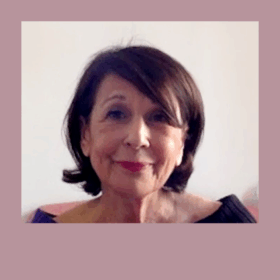Il 3 febbraio 2025 a Parigi si è tenuta la Serata dell’AMP che ha inaugurato il lavoro verso il XV congresso, che si terrà nella primavera del 2026 a Parigi sul tema “Non c’è rapporto sessuale”. Introduzione alla serata di Christiane Alberti, presidente dell’AMP.
Il titolo di questo Congresso, Non c’è rapporto sessuale, richiama immediatamente un’osservazione: è la prima volta che il termine “sessuale” compare nel titolo di un congresso dell’AMP. Ci è dunque data l’occasione di interrogare ciò che ha fatto lo scandalo della scoperta freudiana, ma anche il suo successo se si considera che Freud ha contribuito alla dissoluzione della morale sessuale civile, portando alla luce l’importanza del sessuale nell’economia psichica, fino a puntare la sessualità infantile. Egli ne ha ampliato la significazione ben oltre l’accoppiamento animale e della genitalità, considerando per esempio che nella sessualità infantile (riferendosi al pediatra Lindner[1]) è nel ciucciare che bisogna vedere il prototipo della pulsione sessuale: una rivendicazione primaria, primordiale di voluttà, indipendente dal bisogno vitale, una condizione silenziosa del corpo in relazione con se stesso. Come scrive, in maniera radicale, ne La morale sessuale ‘civile’: la pulsione sessuale fa di testa sua[2].
Dall’epoca di Freud un cambiamento radicale è intervenuto nella sessualità. La sessualità è onnipresente, resa visibile, espandendosi ovunque in rete e sui social. Lacan aveva sottolineato, poco prima del 1968, ne Il mio insegnamento, l’evidenza che il vero cambiamento sta qui: la sessualità ha perso qualcosa del godimento clandestino e trasgressivo per lasciare posto a una sessualità cha ha “qualcosa di molto più pubblico […], alla luce del sole” [3]. Per questo motivo, i soggetti si vedono privati di una parte di intimità e di segreto e come precipitati, fuori di se stessi, sulla scena pubblica. È ancora più presente oggi, all’epoca dello sviluppo della sessualità negli spazi digitali.
Una ricerca recente e ben documentata dell’INSERM sull’evoluzione della sessualità dei Francesi dai 15 agli 89 anni ha recentemente pubblicato dei risultati che meritano di essere considerati[4].
I risultati confermano innanzitutto alcune tendenze che non sono nuove: cambiamenti importanti legati alla promozione della norma d’uguaglianza tra i sessi e le sessualità, e scombussolamenti profondi delle strutture familiari in un contesto in cui la legge estende l’accesso al matrimonio e alla genitorialità.
Il dato più interessante è ciò che viene appuntato come nuovo e definito come “paradosso contemporaneo della sessualità”[5]. È caratterizzato da una maggiore diversità dell’attività sessuale – aumento del numero dei partner, estensione dei “repertori” sessuali (meno penetrazione e più masturbazione) –, contemporaneamente a una minore frequenza dei rapporti sessuali. Queste tendenze sono osservate anche in altri paesi (Germania, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Regno-Unito).
In qualche modo, questi elementi non sono estranei a ciò che si ritrova in chi si rivolge alla psicoanalisi. In particolare è il caso dei soggetti che, nella moltiplicazione sfrenata dei partner, sotto l’imperativo di un godimento permanente e immediato, si abbandonano non al destino fatto loro dall’inconscio ma a un consumo in cui si annulla ogni divisione nella stretta dipendenza corporea; la sessualità raggiunge, così, il regime delle dipendenze come altrettante forme di riempimento del vuoto. È nell’acting che il soggetto si difende dalla vergogna.
Ma sono anche i casi in cui la sessualità viene messa a distanza nella forma della coppia fraterna, il duo allo specchio, nel quale l’illusione di fare uno è portata al suo culmine, nell’evitamento o nel diniego degli imbrogli dell’amore e del desiderio.
In un certo senso, Lacan ci da una lettura di questo cosiddetto paradosso attraverso ciò che chiama, nel Seminario XI, “desessualizzazione”[6]. In un contesto di una civiltà dove l’avere ha preso il sopravvento sull’essere, dove l’oggetto è al comando, gli osservatori contemporanei ritengono che l’ordine erotico si allinei sugli imperativi di mercato, in maniera, possiamo dire, disincarnata, sganciata dall’affetto. Lacan ne dà un’altra lettura, meno semplicista, chiarendo in maniera più precisa ciò che si produce quando gli oggetti della realtà hanno il sopravvento sulla causa intima del soggetto. Egli indica a proposito dell’oggetto orale che la zona erotizzata vale per la soddisfazione pulsionale solo nella misura in cui altre zone, desessualizzate, ne sono escluse. Ma che succede nel movimento contrario, quando è l’oggetto sessuale stesso, il partner, a scivolare verso la china della realtà? Il soggetto, dice Lacan, entra allora in una zona di caduta chiamata funzione della realtà. La realtà prende il sopravvento sul reale pulsionale, la carne sul corpo. Non ci si può vedere una chiave di lettura del disincanto, o cinismo, contemporaneo in materia sessuale?
Il resto dell’inchiesta mette in evidenza fino a che punto la questione dell’aggressione sessuale vi occupa un posto preponderante: un passo è compiuto nell’ordine di una cultura del contratto, in particolare per assicurarsi il consenso[7]. Occorre rileggere Kant con Sade[8] per misurare che una società del contratto, lungi dal farvi ostacolo, incoraggia il cinismo del godimento e di nuove “leggi dell’ospitalità” come il melangismo.
Oggi, l’immaginario della rivalità tra uomini e donne tende a ridursi alla modalità dello scontro, della radicalità senza sfumature. Attraverso le rivendicazioni, è il regime dell’uguaglianza assoluta dei soggetti a prendere il sopravvento sulla differenziazione dei godimenti uomo e donna, la differenziazione dei godimenti tout court, attraverso l’illusione di una condivisione identitaria del godimento. L’assioma sottostante è quello della separazione dei sessi, che lascia ciascuno alla sua solitudine pulsionale.
Si tratta di disfarsi dell’Altro, sempre sospettato di violenza[9], dello stupro dell’essere. La dissimmetria con il grande Altro vi è denunciata come rapporto di dominazione, là dove Lacan afferma che solo l’artefatto dell’Altro rende possibile ciò che è dell’ordine del sesso, del rapporto sessuato[10].
Non ci inganniamo, in tale separatismo non c’è una messa a nudo del non-rapporto, ma una desessualizzazione che prescrive il rapporto sessuale che ci vorrebbe, che lo fa esistere in un diniego.
Questo suppone di tornare al non c’è dell’aforisma non c’è rapporto sessuale. Jacques-Alain Miller lo commenta così nella Conversazione di Arcachon: “Il “Non c’è” di Lacan è la pagina bianca, non è iscritto. Si deve distinguere la negazione di una proposizione scritta dalla non-scrittura di questa proposizione”[11]. J.-A. Miller ne ha proposto una scrittura che rappresenta l’assenza del rapporto sessuale semplicemente con il simbolo dell’insieme vuoto, e scrive sopra “il sigma del sintomo”[12]. In questo non c’è si tratta di un’altra mancanza rispetto a quella della forclusione. Il non c’è rapporto sessuale non è un buco: è un puro non c’è. Dunque è in quanto “inscrivibile, fondabile, come rapporto”[13] che il rapporto sessuale non esiste. Pertanto dovremo interrogarci sul vero valore di ciò che si scrive.
Lacan lo afferma chiaramente ne Lo stordito: “Il non c’è rapporto sessuale non implica affatto che non ci sia rapporto con il sesso”[14]. Che non ci sia rapporto sessuale che sia inscrivibile è precisamente ciò che condiziona che ci siano delle relazioni, – che ci sia qualcosa dell’ordine del sesso –, quelle che rivelano i legami inconsci; quelle relazioni che passano dal godimento, dal corpo e dalla lingua, dal saper-fare dell’inconscio con lalingua, in altre parole dal sintomo. Legami sempre sintomatici dunque. La sessualità può anche essere alla luce del sole, il sesso fa sempre sintomo. Non se ne esce. È qui che la psicoanalisi gioca la sua partita, precisamente in un tempo in cui il sintomo non ha diritto di cittadinanza nei discorsi ed è disinvestito dal soggetto stesso.
Perciò, sulla via di un Lacan connesso al rovescio della vita contemporanea, questo Congresso dovrà interrogare le conseguenze del non c’è sui miti moderni della vita sessuale e amorosa. Al tempo degli Uni-tutti-soli, il desiderio di fare coppia è ancora di attualità? Quando nessuno crede più al programma “a ciascuno la sua ciascuna”, l’amore rimane una supplenza privilegiata al non-rapporto? Quali sono le altre forme di supplenza che la clinica e la pratica portano allo scoperto?
Opacità del sessuale
“La sessuomania dilagante è solo un fenomeno pubblicitario”[15], diceva Lacan nella sua intervista al giornale Panorama. È chiaro, essa non verrà a capo del mistero della sessualità. Infatti, per quanto si stia digitalizzando, come l’ha formulato Éric Laurent, “[il] programma di godimento non è virtuale”[16].
Nel seminario Il Sinthomo, è per l’appunto il termine “opacità sessuale»[17] a catturare l’attenzione. Ogni pensiero, ogni conoscenza, dice Lacan, devono essere riconsiderati] a partire dall’atto sessuale, il linguaggio stesso è in rapporto con il sesso. In una conversazione inedita UFORCA su Il sinthomo[18], J.-A. Miller ha chiarito l’opacità in causa. Essa non sta qui a designare l’impossibilità di dire sul desiderio sessuale. Si presenta piuttosto come una macchia nel campo visivo, il sessuale opacizza il campo visivo, faccia visibile del non c’è. Il riferimento, precisa, non è all’enigma (registro significante), ma all’immaginario del corpo come consistenza del parlessere. Per cui la questione da risolvere sarebbe: “Com’è pensabile che l’altro parlessere adori il suo corpo, e non il mio?” [19].
Questa prospettiva mi sembra appassionante, non per fare luce sull’opacità, ma per accettare che la luce ci riguardi, un modo per non guardare troppo da vicino, affinché il mistero del sessuale persista.
[1] Cfr. S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi [1915-1917], in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino 1976, p. 462-477.
[2] Cfr. S. Freud, La morale sessuale “civile” e il nervosismo moderno [1908], in Opere, vol.5, Boringhieri, Torino 1972, pp. 407-430
[3] J. Lacan, Posto, origine e fine del mio insegnamento [1967], in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 24.
[4] INSERM, Contextes des sexualités en France, 2024.
[5] Ivi, p. 39.
[6] J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p. 151.
[7] Cfr. INSERM, Contextes des sexualités en France, op. cit., p. 40.
[8] Cfr. J. Lacan, Kant con Sade [1962], in Scritti, Einaudi, Torino 1974 e 2002, vol. I, pp. 764-791.
[9] Come indica l’aumento statistico della messa in discussione dichiarata della scelta eterosessuale: per meglio premunirsi dalle agressioni. Cfr. INSERM, Contextes des sexualités en France, op. cit., p. 40.
[10] Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971], Einaudi, Torino 2010, p. 121.
[11] Cf. J.-A. Miller, La Conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Astrolabio, Roma 1999, p. 209.
[12] Ibidem.
[13] J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, cit., p. 121.
[14] J. Lacan, Lo stordito [1972], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 461.
[15] J. Lacan, Freud per sempre. Intervista a Jacques Lacan di Emila Granzotto, in La Psicoaanalisi, n. 41, Astrolabio, Roma 2007, p. 21.
[16] É. Laurent, Il programma di godimento non è virtuale, in Attualità lacaniana, n. 11, Franco Angeli, Milano 2010.
[17] J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 60.
[18] Discorso pronunciato da Jacques-Alain Miller in occasione delle Giornate UFORCA del 21 e 22 maggio 2011 dal titolo Le parlement de Montpellier, Autour du Séminaire XXIII, inedito.
[19] Ibidem.